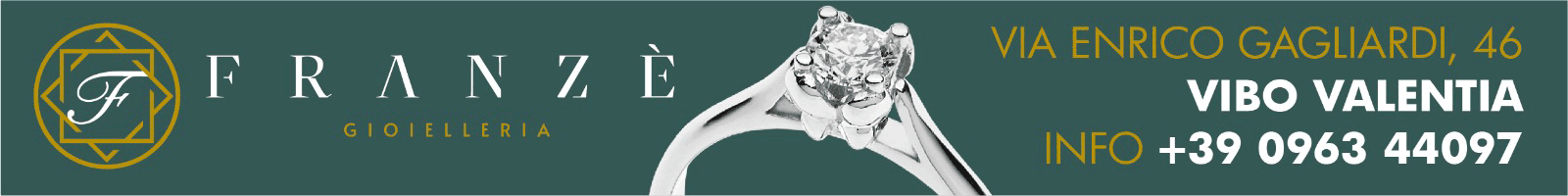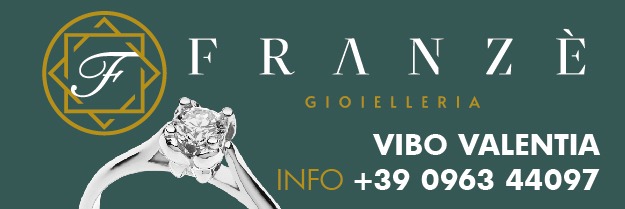Nocera Terinese rivive dopo tre lunghi anni di stop il secolare e identitario rito di autoflagellazione dei “Vattienti”. Centinaia e centinaia di persone in strada per una tradizione “votiva del sangue” che i cittadini di Nocera cercano di tramandare alle generazioni future. Una ricorrenza mista di ancoraggi pagani e tradizioni religiose che si fondono al punto da determinarne la sua forza ancestrale irrinunciabile, fatto simbolico e propiziatorio verso il rinnovamento della natura con l’arrivo della Pasqua per portare avanti un’usanza familiare o per accedere alla società.
I “fedeli penitenti”, durante le processioni di rito, si flagellano battendosi le gambe con le “lanze” – tredici punte di vetro infilate nel sughero, a simboleggiare i dodici apostoli più Gesù – fino a sanguinare. Durante il percorso, accanto al ‘vattiente’ c’è sempreun amico che ha il compito di seguire il flagellante, versandogli il vino per pulire le ferite. Il vino serve a disinfettare e, allo stesso tempo, a mantenere aperte le ferite, favorendo il defluire del sangue. Il ‘vattiente’ è seguito anche dall’Acciomu, ecce homo in latino, legato fisicamente al ‘vattiente’ da una corda. Quest’ultimo indossa un lembo di stoffa rossa e una croce il cui simbolo evidente è la passione di Cristo. Insieme percorrono le strade del paese, visitando parenti e amici, per poi arrivare alla processione della Madonna Addolorata: di fronte alla statua si fanno il segno della croce, si percuotono e versano il loro sangue ai piedi della Vergine. L’atto finale del rito.
I “fedeli penitenti”, durante le processioni di rito, si flagellano battendosi le gambe con le “lanze” – tredici punte di vetro infilate nel sughero, a simboleggiare i dodici apostoli più Gesù – fino a sanguinare. Durante il percorso, accanto al ‘vattiente’ c’è sempreun amico che ha il compito di seguire il flagellante, versandogli il vino per pulire le ferite. Il vino serve a disinfettare e, allo stesso tempo, a mantenere aperte le ferite, favorendo il defluire del sangue. Il ‘vattiente’ è seguito anche dall’Acciomu, ecce homo in latino, legato fisicamente al ‘vattiente’ da una corda. Quest’ultimo indossa un lembo di stoffa rossa e una croce il cui simbolo evidente è la passione di Cristo. Insieme percorrono le strade del paese, visitando parenti e amici, per poi arrivare alla processione della Madonna Addolorata: di fronte alla statua si fanno il segno della croce, si percuotono e versano il loro sangue ai piedi della Vergine. L’atto finale del rito.
Le polemiche alla vigilia
L’attesissimo rito è andato, dunque, in scena dopo giorni di passione per l’ordinanza commissariale che ne vietava lo svolgimento. “La pratica dello spargimento di sangue per le vie cittadine, unita all’apposizione dello stesso sulle mura degli edifici – aveva scritto la Commissione nell’ordinanza con cui aveva imposto il divieto – è in assoluto contrasto con le primarie esigenze di tutela della salute pubblica e salubrità dell’ambiente”. La revoca del divieto è stata disposta dopo un incontro tra i componenti della Commissione comunale, i rappresentanti delle associazioni locali e le autorità sanitarie.
Nella nuova ordinanza della Commissione si è stabilito che “iI percorso del partecipanti al rito” è coinciso “in gran parte con quello già previsto dalle processioni religiose organizzate in occasione del Venerdì e del Sabato Santo, con espressa eccezione di luoghi pubblici quali scuole, esercizi pubblici, sedi municipali, comando stazione carabinieri ed altri analoghi”. I rappresentanti dei cittadini e delle associazioni, inoltre, si sono impegnati “a raccomandare ai partecipanti alla pratica dei ‘vattienti’ che il numero massimo consentito, in contemporanea e per singola processione, non superi le venti unità”. Ciascun ‘vattiente’ ha dovuto usare strumenti di uso strettamente personale, opportunamente igienizzati prima e dopo ciascun utilizzo, e ha dovuto mantenere una distanza di almeno cinque metri da ogni altro praticante il rito. Non ammessi imbrattamenti con sangue e altri fluidi corporei di pareti e portoni di edifici pubblici e privati”.
La storia del rito
Il rito, che risale al 1473, ha una storia controversa: in passato è stato formalmente condannato dal Vaticano, tanto che i ‘vattienti’ erano in via di estinzione e la pratica fu in alcuni casi anche vietata dalle forze dell’ordine. Fino al 1997, quando la cerimonia è tornata in auge. Una tradizione che si tramanda da padre in figlio in Calabria: una cerimonia suggestiva che provoca, a volte, degli svenimenti dei presenti. I ‘vattienti’ si colpiscono ripetutamente le gambe con il ‘cardo’, un disco di sughero sul quale, con uno strato di cera sono infissi tredici pezzetti di vetro acuminati, e con la ‘rosa’, sempre di sughero lavorato con scanalature per fare scorrere il sangue prodotto dalle ferite.